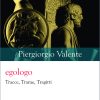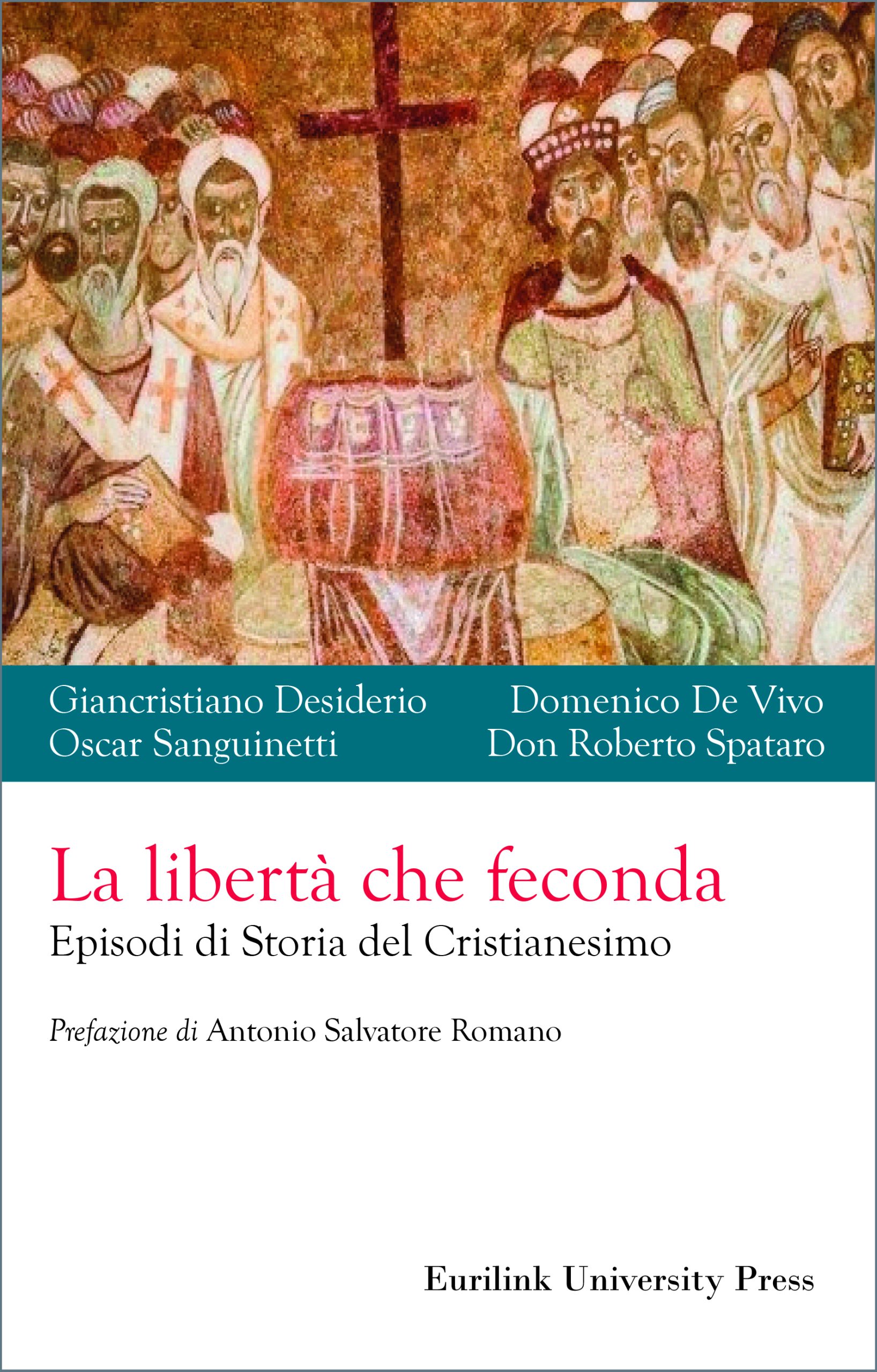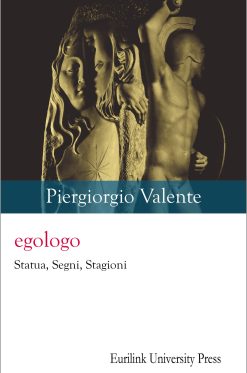Novembre 2025
pp. 108
COLLANA: Historia – 8
ISBN 979 12 80164 97 1
Prefazione di Antonio Salvatore Romano
Ogni generazione – per non dire ogni uomo – ha bisogno di ricreare nel suo spirito le verità disperse nella storia. Il libro, frutto del contributo di quattro illustri autori, parte dalle considerazioni sul saggio di Benedetto Croce “Perché non possiamo non dirci cristiani” che uscì sulla rivista “La Critica” il 20 novembre 1942 ossia nel bel mezzo della Seconda guerra mondiale. Gian Cristiano Desiderio prende quindi le mosse dalla situazione storica e dalle reazioni che ci furono in campo politico e si allargherà allo stesso pensiero del filosofo e alla sua battaglia ideale e pratica per la difesa della libertà. Con Domenico de Vivo, il volume passa ad esaminare le fonti dirette delle origini del Cristianesimo e le testimonianze storiche antiche non cristiane. Sono solo una decina gli storici ed autori antichi che costituiscono le fonti indirette delle origini del cristianesimo e affondano le radici nel contesto storico e culturale dell’Impero Romano: rispettando un ordine cronologico si parlerà del c.d senaconsulto del 35e di pochi autori, fra i quali i tre latini sempre considerati: Plinio il Giovane, Tacito e Svetonio. Ciò che Socrate ha significato per la storia dell’antica filosofia greca – ci ricorda Roberto Spataro – è stato Origene per la storia del Cristianesimo antico. Con Origene iniziano l’esegesi biblica sistematica, fondata su una precisa teoria ermeneutica e la teologia tout court, intesa come rigorosa ricerca intellettuale dei dati della Rivelazione accolti con fede. L’eredità di Origene fu raccolta dai suoi estimatori tra i quali si annoverano, in Oriente, i Padri Cappadoci e, in Occidente, personalità della statura di Ambrogio. Nella quarta parte, Oscar Sanguinetti, ci parla del cristianesimo nell’epoca costantiniana: con Costantino I, che regna dall’inizio del IV secolo, il culto cristiano viene riconosciuto ufficialmente. Dopo la sua vittoria a Ponte Milvio, Costantino interrompe le persecuzioni e nel 313 emana l’Editto di Milano, che garantisce libertà di culto. Costantino chiama anche alla conversione al cristianesimo e sostiene l’unità della Chiesa, convocando il Concilio di Nicea nel 325 per affrontare le eresie. Il termine “Chiesa costantiniana” è stato usato per criticare la Chiesa prima del Concilio Vaticano II, sostenendo che si sarebbe contaminata con il potere temporale.
Giancristiano Desiderio, è tra i maggiori studiosi italiani dell’opera di Benedetto Croce e un interprete del suo liberalismo. Ha pubblicato saggi su Croce, Einaudi, Machiavelli, Vico, Hegel, Marx, Berlin. Scrive per il Corriere della Sera.
Domenico De Vivo, Avvocato e cultore di Storia Romana (I e II secolo). Laureato presso l’Università “Federico II” di Napoli. Già borsista della Luiss di Roma e del Formez. È autore di varie pubblicazioni. Cultore di Storia Romana con il prof. G. Guadagno all’Università di Salerno. Coautore per la Eurilink University Press del volume “Sistema Uzbekistan” (2021).
Oscar Sanguinetti ha insegnato Metodologia della Ricerca Storica all’Università Europea di Roma ed è stato ricercatore in scienze umane presso il CNR di Roma; dirige l’Istituto Storico dell’Insorgenza e per l’Identità Nazionale di Milano e pubblica a Milano il trimestrale “Cultura & Identità. Rivista di studi conservatori”.
Don Roberto Spataro, sacerdote salesiano, dottore in Teologia dogmatica e in Lettere classiche, è autore di vari libri e oltre cento articoli. Socio della Pontificia Academia Latinitatis e del Gruppo Italiano di ricerca su Origene e la tradizione alessandrina, collabora all’edizione dell’Opera Omnia di Origene per Città Nuova.