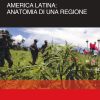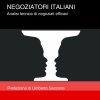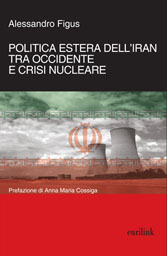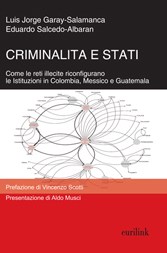Marzo 2022
pp. 154
COLLANA: Tempi Moderni – 28
ISBN: 979-12-80164-21‑6
Il 2020 ha sancito il cinquantenario della ricostruzione dei rapporti diplomatici tra Italia e Cina ed avrebbe dovuto essere anche occasione di gemellaggio per la cultura ed il turismo tra i due paesi. Tuttavia l’annus horribilis dell’emergenza sanitaria globale ha costretto il mondo a rivedere i propri progetti e ripensare nuove scadenze, così che anche il gemellaggio sino-italiano e la celebrazione del cinquantenario sono stati rimandati al 2022. Intanto i rapporti tra il colosso asiatico e l’Occidente si sono fatti sempre più tesi e complessi; la propulsione atlantista e anticinese consolidata dall’ ascesa di Biden si sta manifestando in modo sempre più proattivo in quasi tutto l’Occidente; non è peregrino immaginare che possa in futuro riflettersi anche sui rapporti bilaterali Italia-Cina che da sempre sono pacifici e di proficua amicizia. Ed è proprio in virtù di questo contesto cosi teso che è invece necessario promuovere i valori del multilateralismo e ritrovare nella cultura lo strumento per eccellenza di reciprocità, dialogo e diplomazia. Nel 2007, il presidente Hu Jintao aveva sottolineato quanto e come la cultura di un paese fosse fonte crescente di coesione sociale e creatività, nonché un fattore di estrema importanza nel rafforzamento del potere nazionale a livello globale. Così, la necessità di promuovere all’ esterno un’immagine di identità nazionale forte e coesa, ha spinto molto sull’ implementazione di discipline quali l’archeologia ed il restauro, nonché sulla apertura continua di musei che nel gennaio del 2020 erano circa 5.788, con un numero annuo di visite che è passato a 1,2 miliardi rispetto ai 700 milioni del 2016. L’ inclusione strategica della promozione culturale quale pilastro delle relazioni internazionali e della crescita del paese è evidentemente prioritaria ormai da diversi anni: la stessa Via della Seta tenderebbe a costruire un hub culturale dialogante, nel quale il paese possa stagliarsi con tutta la sua forte identità. Lo scopo del testo è quello di aprire una discussione sulle sfide delle politica culturale nella Cina contemporanea ed esplorare, per quanto possibile, i contesti nazionali ed internazionali che ne influenzano la costruzione. La diplomazia, l’economia, l’identità nazionale, la rielaborazione di un nuovo sé e la proiezione della propria immagine nel mondo provano a diventare lenti diverse e complementari attraverso cui leggere storia ed obiettivi di un paese che, nonostante sia diventato la seconda potenza mondiale, conosciamo ancora troppo poco.
Daniela Caruso è sinologa, da diversi anni si occupa delle trasformazioni storiche della Cina contemporanea con un particolare sguardo all’ evoluzione del welfare, ma anche delle politiche culturali e scientifiche. Attualmente è docente di Studi sulla Cina presso l’Università Internazionale per la Pace delle Nazioni Unite, la cui struttura di Roma è delegata a rappresentarla nel Sud Est europeo, nel Medio Oriente, nel bacino del Mediterraneo e nell’Africa Settentrionale e Sub-sahariana. E’ stata visiting professor alla Tshingua University di Pechino dove ha tenuto seminari di comunicazione interculturale. Membro dell’European Association for Chinese Studies (EACS), docente presso L’École des hautes études en sciences sociales e il dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, ha coordinato progetti di ricerca internazionali inerenti l’interculturalità, le politiche sanitarie in Cina, le migrazioni e le relazioni tra la Cina e il Mediterraneo. Autrice di numerose pubblicazioni in lingua inglese, la sua ultima monografia in lingua italiana, “Quarant’anni di Cina. La storia di un’ascesa che sta cambiando il mondo” è del 2018 ed è stata pubblicata da Eurilink University Press.
INTERVISTA ALL’AUTRICE
VIDEOINTERVISTA ALL’AUTRICE
RECENSIONE